FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA...
Negli ultimi anni si fa un gran parlare di Dislessia, Disturbo Specifico di Apprendimento, ecc. ma anche degli evidenti errori di diagnosi in questo settore delle neuroscienze, che hanno trasformato questi disturbi in un'apparente epidemia.
La British Dyslexia Association descrive la dislessia come "una difficoltà di apprendimento che colpisce principalmente le competenze coinvolte nella lettura accurata e fluente e nell'ortografia" ed è caratterizzata da "difficoltà di consapevolezza fonologica, memoria verbale e velocità di elaborazione verbale ".
In realtà, da sempre, la definizione di Dislessia porta con se molta confusione ed approssimazione. Mentre Adams (1969) incontra ben 32 diversi significati riferibili alla Dislessia, Cornwall ed al. (1984) fanno una sarcastica considerazione:
"Se un bambino diagnosticato come dislessico in Philadelphia dovesse trasferirsi presso la contea di Bucks, solo dieci miglia a nord, verrebbe definiito come bambino con ritardo del linguaggio. Nella contea di Montgomery in Maryland, poche miglia a sud, la diagnosi cambierebbe ed il bambino sarebbe visto come caratterizzato da problemi speciali o specifici di linguaggio. In Michigan verrebbe chiamato bambino con disturbi percettivi. In California sarebbe considerato poratore di handicap educativi o neurologici, mentre in Florida e nello stato di New York sarebbe consideratoun cerebroleso"
Hydn e Cohen (1983) dicono che si possa accettare la diagnosi di dislessia soltanto se accompagnata da accertamenti che dimostrino effettivi disturbi del sistema nervoso centrale globale, nel cervelletto, nelle funzioni sensoriali, ecc.
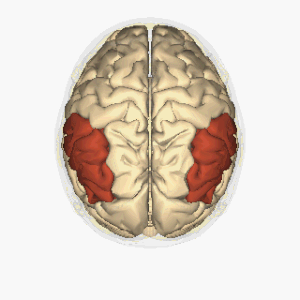
Lobulo parietale inferiore (vista superiore). Alcuni dislessici mostano una riduzione dell'attivazione elettrica in questo settore.
Il Prof. Paolo Meazzini (2002), noto esperto nel campo della terapia cognitivo-comportamentale e psicoterapia evolutiva, fa delle considerazioni importanti riguardo ai costi di cattive diagnosi che "affibbiano" l'etichetta di dislessico. Al di là dei costi sociali e di salute pubblica, l'etichetta di dislessico purtroppo condizionerà l'intera vita del bambino. Infatti in questa occasione l'atteggiamento, durante il cammino didattico, sarà quello di considerarlo un caso patologico che va contenuto e non può guarire. Ma con una cattiva diagnosi si impedirà soltanto il recupero di normali capacità visive e quindi di un adeguato apprendimento.
Una delle definizioni della Dislessia considerate più legittima è quella dell'I.R.A. (the International Reading Association) che dice: "Il termine Dislessia si applica a persone che hanno vista, udito, intelligenza e funzioni del linguaggio del tutto normali".
Meazzini (2002) aggiunge riguardo alla dislessia evolutiva "evidentemente la stragrande maggioranza degli allievi italiani considerati dislessici hanno avuto semplicemente la sventura d'imbattersi in operatori, come dire un pò dislessici, inabili cioè a leggere ed a ben interpretare la lettura scientifica più recente. (omissis)...su 100 cattivi lettori solo una percentuale trascurabile (dal 7% al 10%) rientrerebbe all'interno di tale patologia."
Ma allora vediamo quali possono essere le cause di queste difficoltà!
Possiamo innanzitutto renderci conto di un fatto molto semplice ed evidente, come descrive Tinker (1965): il nostro apprendimento avviene principalmente attraverso la lettura, prima delle singole lettere e la loro fonetica, poi della composizione di parole e quindi della composizione di frasi con la formazione di concetti.
Se alla base delle prime esperienze di apprendimento non viene garantita una funzione visiva adeguata tutto il processo di apprendimento verrà profondamente condizionato.
Una funzione visiva adeguata non corrisponde alla capacità di leggere nitidamente lettere da lontano o da vicino (quello a cui si riduce generalmente il controllo visivo dei nostri piccoli) ma richiede un'analisi attenta dei movimenti saccadici, dell'ampiezza accomodativa, della facilità accomodativa, del coordinamento visuo-motorio ed altri aspetti della "Funzione Visiva" in quella che comunemente viene chiamata Analisi Visiva.
Guardando la questione da un altro punto di vista, come afferma Griffin (1997), i disordini visivi come ipermetropia, insufficienza di convergenza, riserve fusionali ridotte, disparità di fissazione, iperforia, anisometropia, disfunzioni accommodative, movimenti saccadici ridotti e in sostanza procesi percettivi visivi inefficenti sono stati indicati, nella maggioranza delle ricerche scientifiche, come fattori che condizionano negativamente la lettura.
Lo stesso Griffin (1997) fa una considerazione che si ricollega sia alla necessità di non "etichettare" frettolosamente un problema di lettura come qualcosa di non trattabile e conseguentemente di valutare il problema in modo adeguato con la possibilità di un trattamento fondamentalmente visivo: "Nei problemi di lettura è forse più appropriato usare il termine "disfunzione" piuttosto che disabilità o disordine, visto che questi ultimi termini possono implicare l'impossibilità di un trattamento. Molte forme di Difficoltà di Lettura possono essere eliminate completamente con l'intervento diretto di un optometrista. Alcune di queste possono essere solo parzialmente migliorate ed altre possono essere identificate dall'optometrista ma dovranno poi esssere trattate da altri professionisti".
Pavlidis (1981), Miles & Miles (1983), Everatt (1999), Livingstone et al. (1993) e Meazzini e Fagetti (1988) riscontrano nelle loro ricerche una componente visiva nei problemi di lettura, inclusa la dislessia, ma non riescono in realtà ad indicare cosa cambi fra dislessici e non e quali siano i test ai quali dovrebbero essere sottoposti questi soggetti per una diagnosi differenziale.
E' qui che entra in campo l'optometrista, come indica Griffin et al (1997) con test appropriati che possano discernere Difficoltà di Lettura dovute a problemi funzionali o altre situazioni che abbiamo visto possano comunque ricevere stimoli importanti per un miglioramento.
Reference
- Adams R.B. (1969) Dyslexia: a discussion of its definition. Journal of Learning Disabilities, 2, 616-626.
- Cornwall K.F., Hedderly R. e Pumfrey D. (1984) Specific Learning Difficulties: the specific learning difficulties versus dyslexia controversy resolved? Occasionally Papers of the Division of Educational and Child Psychology of the British Psichological Society
- Everatt J. (1999) Reading and Dyslexia. ed. Routledge, London
- Griffin J.R., Christenson G.N., Wesson M.D., Erickson G.B., Optometric Management of Reading Dysfunction. (1997) ed.Butterworth-Heinemann
- Hydn e Cohen (1983) Dyslexia ed. Grune e Stratton, New York
- Livingstone et al. (1993) Parallel processing in the visual system and the brain: is one subsystem selectively affected in dyslexia? in Galabaruda, AM (ed.), Harvard Univ. Press Candbridge.
- Meazzini P. e Fagetti M.A. (1988) La lettura ed i suoi errori: procedura d'intervento sugli errori di omissione e d'inversione H.D. Giornale Italiano di Psicologia e Pedagogia dell'handicap e delle disabilità d'apprendimento, 21, 12-17.
- Meazzini P., La lettura negata ovvero la dislessia e i suoi miti. (2002) ed.FrancoAngeli.
- Miles T.R. & Miles E. Help for Dyslexic children. ed. Methuen, London.
- Pavlidis G. (1981) Do eyes movements hold the key to dyslexia? Neuropsycholgia, 19, 57-94.
- Tinker M.A. (1965) Bases for Effective Reading MInneapolis: University of Minnesota Press, 1965; 3-4.
Luca Ieri
Optometry Doctor - State University of Latvia
Esperto in tecniche visuo-posturali
Membro AID (Associazione Italiana Dislessia)
ATTENZIONE: si ricorda che all'interno degli articoli di questo Blog vengono usati termini e concetti semplificati per un pubblico non professionale e a scopo puramente divulgativo.

















